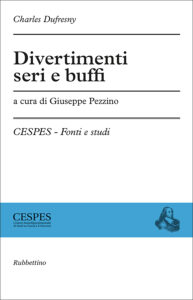(…) per Dufresny, divertirsi significa cercare il modo più piacevole di colmare, col vino della risata, il calice di un’esistenza che odora di finitudine e di morte. E poiché «la vita stessa non è che un divertimento in attesa della morte», divertirsi divertendo i suoi lettori è forse il modo meno brutto d’ingannare il tempo, sostituendo al desiderio deludente della durata il fascino del gioco e il piacere dell’istante (G. Pezzino)
Il 3 novembre 2015 nasce il CESPES, Centro Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento dell’Università di Catania. È il punto di arrivo di un lungo lavoro preparatorio, che ha visto i professori Giuseppe Pezzino e Maria Vita Romeo (oggi direttrice del Centro) impegnati nell’elaborazione e nella realizzazione di un progetto che, coniugando il momento della ricerca con quello della didattica, mirava all’approfondimento di alcuni aspetti del pensiero filosofico e scientifico di Blaise Pascal. Lavoro iniziato nel 2003, caratterizzato da un’intensa attività seminariale, in sinergia con l’Université B. Pascal di Clermont-Ferrand, la Società Filosofica Italiana e il Fondo Sociale dell’Unione Europea, che ha man mano consacrato Catania come uno dei centri pascaliani di livello internazionale. Ricordiamo Giornate Pascal: «L’incerto potere della ragione» (2003); Giornate Pascal: «Abraham: individualità e assoluto» (2004); Giornate Pascal: «Il moderno fra Prometeo e Narciso» (2005); convegno internazionale «Port-Royal e la filosofia» (2010); convegno internazionale «Ricchezza e importanza degli Opuscoli pascaliani». Il Centro, oltre ad avere un buon numero di sostenitori fra studiosi e studenti, è oggi affiancato da un’autonoma associazione, “Amici del CESPES”, presieduta dal professore Francesco Belfiore.
Sempre nella fase preparatoria sono nate la rivista Quaderni leif (oggi organo del CESPES) e la collana “dialogos” dell’editrice CUECM (Catania) che sin qui conta 17 pubblicazioni, fra cui la più recente è Ricchezza e importanza degli Opuscoli pascaliani (2016). Il CESPES, dopo avere ereditato la rivista e la collana, ha creato in aggiunta due prestigiose collane: la prima, Biblioteca del Cespes (Morcelliana, Brescia), diretta da Domenico Bosco e Maria Vita Romeo, che presenta la traduzione italiana di corpose e fondamentali opere critiche come J. Mesnard, Sui “Pensieri” di Pascal; Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal; J. Laporte, Il razionalismo di Descartes; la seconda CESPES – Fonti e Studi (edita da Rubbettino), diretta da Domenico Bruno, Carlo Carena e Maria Vita Romeo. Quest’ultima presenta la traduzione italiana di “perle” del Seicento europeo, corredate da saggi introduttivi e rigorosi apparati critici di autorevoli studiosi, opere agili e interessanti come J.-B. Bossuet, Trattato sul libero arbitrio, a cura di Maria Vita Romeo; Allocuzioni di Immortali. Discorsi all’Accademia francese fra Sei e Settecento, a cura di Mario Richter; J.-B. Bossuet, Trattato sulla conoscenza di Dio e di se stessi, a cura di Elisabetta Todaro; Charles Dufresny, Divertimenti seri e buffi, a cura di Giuseppe Pezzino. Ed è con il professore Pezzino, per un trentennio docente all’Università di Catania, autore di numerosi saggi, che parliamo di filosofia morale e dell’opera di Dufresny (Parigi 1657 – Parigi 1724), scrittore prolifico e poliedrico, che spazia dalla riflessione morale alla poesia, dalla satira al teatro.
Sintetizzando il panorama filosofico del Seicento, quali autori e quali correnti di pensiero emergono in generale e per quanto riguarda la filosofia morale nello specifico? Per il Seicento francese (ma non solo francese!) bastano due giganti della filosofia e della scienza: René Descartes e Blaise Pascal. Un particolare importante: gli intellettuali che vivono in solitudine accanto al monastero di Port-Royal (Antoine Arnauld e Pierre Nicole, per citare solo i più noti) e che sono definiti “giansenisti”, rappresentano un fenomeno importantissimo nella modernità del Seicento: a Port-Royal si crea un fecondo intreccio a livello europeo tra la filosofia cartesiana e la teologia agostiniana. Sul terreno della teologia e della filosofia morale, gli intellettuali “giansenisti” di Port-Royal (assieme a Pascal) saranno protagonisti di uno storico scontro con i gesuiti e le loro spregiudicate teorie miranti a legittimare la rilassatezza morale.
In questo scenario Dufresny è forse il pensatore meno noto, ma interessante al pari di nomi della filosofia morale più “blasonati”. Innanzi tutto bisogna collocare Charles Dufresny nella linea secentesca di pensatori e scrittori francesi, definiti “moralisti”, del calibro di un Pascal, di un La Rochefoucauld e di un La Bruyère. Costoro ci hanno lasciato tesori di riflessioni e di descrizioni critiche sull’uomo e sulla società. Per tanto tempo Dufresny è stato posto in ombra dai grandi moralisti sopra citati, ma oggi stiamo scoprendo il valore della sua opera, Divertimenti seri e buffi, che in maniera intelligente e divertente ci parla di cose serie ed eterne, perché eterna è l’anima umana. Dufresny è un uomo di teatro, scrive parecchie commedie, dirige il «Mercure Galant», e da uomo di teatro immagina un «viaggio» di uno straniero proveniente dal Siam, che viene catapultato fra le «follie» di una Parigi che, nel bene e nel male, è lo specchio del mondo moderno di allora. In verità, lo straniero venuto dal Siam non è un personaggio ma un gioco spiritoso, un gioco molto serio, che permette proprio a Dufresny di effettuare il suo viaggio nel pianeta uomo e dintorni. E il nostro moralista offre al lettore una miscela di serio e di buffo che non può non sedurre il lettore, dal momento che l’uomo e la vita sono una miscela di serio e di buffo.
Come si è modificata attraverso i tempi la riflessione sulla società e quindi la filosofia morale? Poiché la filosofia morale, come sappiamo, non è una passeggiata fra le nuvole ma una rigorosa riflessione sull’uomo e quindi sulla società, è evidente che il pensiero filosofico ha sempre modulato il suo intervento in riferimento ai mutamenti della società. E questo affiatamento tra pensiero e società fa sì che le condizioni di salute di questa si riflettano sugli interventi di quello. Per cui, in una società che perde sempre più la propria memoria, la propria identità, il proprio essere nel mondo e nella storia, tutto nel campo del pensiero si fa debole, liquido, relativo. E la filosofia diventa la religione del pantheon, del tempio dedicato e aperto a tutti gli dèi, perché non si crede a nessun dio.
Che ruolo ha oggi la filosofia morale? Preferisco parlare sinteticamente del ruolo che dovrebbe o non dovrebbe avere la filosofia morale! La navicella della filosofia deve navigare arditamente nel mare spesso tempestoso della realtà, ma deve evitare almeno due pericolosi scogli: quello della subordinazione alla politica (in tempi più gloriosi, Vittorini si scagliò contro la cultura che suona il piffero per la rivoluzione!); e quello dell’auto-referenzialità accademica (Benedetto Croce, ad esempio, rispettava l’università, ma deplorava l’«universitarismo» fatto da compilatori di titoli per concorsi!). Ma, per navigare bisogna possedere una bussola e una mèta. Perciò la filosofia morale, traendo orientamento da una costellazione di valori, dev’essere educazione etico-politica in senso alto e nobile. E in una società come la nostra, ammorbata da mali nuovi che si sommano agli antichi, la filosofia deve contribuire alla formazione dell’uomo nuovo per una società nuova, dove donne e uomini liberi possano scegliere il loro futuro e creare una classe dirigente in cui non vi sia posto per i fanatici, per i disonesti e per gli opportunisti. E dove la stella polare dev’essere il bene comune che non nega il bene di ciascuno.
Se dovesse scegliere un pensiero di Dufresny che sente attuale in maniera molto forte,quale sceglierebbe? Fra i tanti, ne sceglierei uno che riguarda il cortigiano del Seicento e l’eterno cortigiano che c’è in noi: «L’innata disposizione dei cortigiani è di non dare nulla a quelli che hanno bisogno di tutto, e di dare tutto a quelli che non hanno bisogno di nulla […] strisciare e domandare costituiscono tutti i loro intrighi».
Altre Rassegne
- Francofonia 2018.10.05
C. Dufresny, Divertimenti seri e buffi - Studi Francesi 2018.07.10
Rassegna bibliografica
di Monica Pavesio - Connessioni 2017.11.19
Le riflessioni morali di Dufresny nella collana del CESPES edita da Rubbettino Intervista a Giuseppe Pezzino
di Maria Teresa D'Agostino