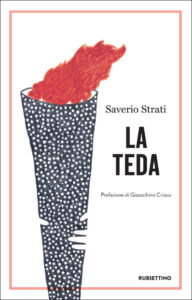«Camminavamo da più di quattr’ore per quelle brutte strade delle montagne di Terrarossa, che è un paesetto proprio nel cuore dell’Aspromonte. Eravamo quattro muratori: io, Costanzo, mastro Cosmo e mastro Gianni. Parlavamo di tante cose. “A Terrarossa la gente fa luce con la deda” diceva Costanzo, che già c’era stato, a Terrarossa. “E com’è possibile fare luce con una scheggia di pino?” fec’io. “Lo vedrai da te” mi disse Costanzo. “Non c’è la luce elettrica come al nostro paese; né usano il petrolio o la lumiera ad olio. A Terrarossa c’è altra gente, altro modo di vivere”. Non riuscivo ad immaginare gente diversa da quella del mio paese, io. “Io non capisco come può essere questa gente!” esclamai. (…) “Non è che la gente sia diversa dalla nostra o da noi stessi, ma è il paese che è diverso. Non c’è la strada rotabile, manca la farmacia, il medico non c’è mai. È l’ambiente che è disgraziato. E tutto dipende dall’ambiente”».
C’è un luogo della Calabria narrato quanto Africo? Da Zanotti Bianco a Stajano a Gioacchino Criaco, al film di Calopresti tratto dal libro di Pietro Criaco, sono stati in tanti a raccontare un paese di fascino primigenio, come bloccato in un ferma-immagine, quasi una piccola Pompei, dall’alluvione del 1951.
Il primo a farne materia di romanzo è stato Saverio Strati, con La teda, pubblicato nel 1956 da Mondadori ed ora ripubblicato, nell’ambito della ristampa di tutte le sue opere, da Rubbettino.
Il quindicenne Filippo arriva a Terrarossa, nome dietro cui si cela Africo, contento «perché non avevo mio padre vicino e divenivo più libero, incominciavo a diventare più importante. Ora mi davo perfino ad amoreggiare con le donne che lavoravano con noi. Prima non le potevo neppure guardare, le donne, con mio padre che non mi dava un po’ di respiro, con mio padre che non mi dava pace con le sue prediche. Ora no, incominciava una vita nuova per me.» Desidera «essere un bravo muratore. Essere come mastro Gianni, che sapeva fare tutto, e come mastro Antonio, che pigliava un progetto in mano e te lo leggeva», dimostrare al padre di essere migliore del saggio Costanzo che, fidanzato della sorella, sarebbe presto diventato suo cognato. Ma il suo interesse primo – una frenesia, un’agitazione fisica e mentale – riguarda le donne: da corteggiare e, soprattutto, da possedere, anche con la violenza. Un atteggiamento che rischia di metterlo nei guai e che viene ampiamente ripreso dai suoi compagni: non perché offende le donne, bensì perché manca di rispetto ai padri, ai fratelli delle donne cui rivolge le sue attenzioni. Il grido tra le lacrime della dolce Cicca – «è meglio nascere capra che donna a Terrarossa!» – ben esprime la particolare subordinazione delle donne, in una realtà in cui la stragrande maggioranza della popolazione è subordinata e marginale.
Torrerossa è un paese poverissimo dell’Aspromonte, senza una strada che lo raggiunga. Lo abitano braccianti sfruttati da pochi possidenti, pastori senza mandrie e contadini dalla scarsa terra. Non c’è un medico, si muore facilmente di polmonite. Si mangiano segale e pane di lenticchie nere, spesso solo castagne; non arriva neppure la poca farina che, secondo le disposizioni del regime, toccherebbe agli abitanti. Siamo agli sgoccioli della seconda guerra mondiale, molti giovani si trovano sotto le armi, chissà dove; le donne aggiungono a lavori più tradizionalmente femminili, anche più pesanti fatiche.
Filippo si trova davanti al perverso intreccio di interessi tra i ricchi proprietari, il potere politico, rappresentato dal potestà e dai carabinieri, e gli uomini d’onore che produce una miseria senza fine: «Se io sapevo scrivere, parlavo di Terrarossa. Ma nessuno mi credeva. Perché davvero non c’era da credere che la gente viveva a quel modo. Se io stesso non vedevo, non credevo.» Quando arriva il principale che paga i braccianti togliendo loro soldi e diritti, Filippo comincia a comprendere le cause di tanta grande ingiustizia – «Sentivo d’avere imparato tantissime cose, in poche ore. Mi pareva di essere cresciuto di dieci anni. Tutto mi cominciava ad essere chiaro» – e la necessità di allargare la propria visione del mondo grazie alla lettura.
Pervaso – come a suo tempo scrisse Vittorini – da allegro stupore e ingenua malinconia, La Teda è un romanzo di formazione e, insieme, un racconto neorealista che, a distanza di tanti anni, non ha perso la capacità di dare voce e corpo alla questione meridionale.Con una denuncia forte delle problematiche culturali, economiche e sociali (Strati è tra primi a indicare con chiarezza l’emergere della ‘ndrangheta), che non si risolve in vittimismo né in disperazione, ma piuttosto in volontà d’azione: «Sentivo che tutto il mondo si doveva allargare e che diveniva luminoso e pieno di nuove voci e di nuovi suoni. Sentivo tante cose in cuore che non vi so dire, e non desideravo altro che la guerra finisse domani, per vedere prestissimo le nuove cose che sorgevano, per ripigliare il lavoro con altro amore»
Narrato in una prima persona che segue sia gli eventi sia i pensieri di Filippo, privo di retorica, dalla lingua scarna e veloce, che non disdegna l’iterazione, e dalle rade ma potenti immagini, ricco di dialoghi di grande vivacità, il romanzo di Strati raggiunge livelli di altissima letteratura nella descrizione dell’alluvione che distrugge il paese. Una pioggia che richiama – per potenza narrativa – quella manzoniana che lava via la peste.
Altre Rassegne
- Il Quotidiano del Sud 2020.07.09
La teda, romanzo corale e di formazione
di Giuseppe Italiano - zoomsud.it 2020.06.07
LE RECENSIONI di MARIA FRANCO. La Teda, Saverio Strati, Rubbettino - Il Quotidiano del Sud 2020.05.15
Strati, scelta della semplicità per scrivere «senza trucchi»
di Domenico Talia