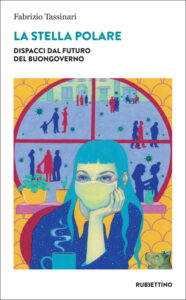Un sistema equo prevede una classe di migliori a capo di una burocrazia efficiente chiamati a prendere decisioni importanti che la politica deve rispettare. Nei Paesi nordici, spiega Fabrizio Tassinari in “La Stella Polare” (Rubbettino), il vero scandalo è se la pubblica amministrazione asseconda le volontà di chi è al governo. Per loro «tecnocrazia» non ha nessuna connotazione negativa.
Mi ha sempre incuriosito la somiglianza dei cognomi scandinavi. Nel quarto di secolo fra il 1993 e il 2018, si sono succeduti tre primi ministri in Danimarca, tutti chiamati Rasmussen senza essere imparentati.
La curiosità venne in parte soddisfatta quando mi capitò fra le mani un libro del 1965 scritto da C.H. Hermanson, dal titolo “Monopolio e Finanza: le quindici famiglie”. Il libro narra nel dettaglio la storia delle famiglie più influenti di Svezia. In esso ha trovato un senso la mia impressione di essere di fronte a un’élite ristretta, che in Paesi piccoli giunge a occupare inevitabilmente la maggioranza degli incarichi di potere.
Unico nel suo genere per spirito egalitario, il tanto ammirato modello scandinavo può trarre in inganno. Anche al Nord c’è una plutocrazia di individui che si spartisce le posizioni apicali in tutti i campi del vivere civile.
Ma diversamente dal resto dell’Occidente, la casta scandinava non è vituperata o osteggiata. Non c’è in Scandinavia indignazione il famigerato “1%” dei Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, che magari elude il fisco ma scarica milioni in una fondazione che lo beatifica agli occhi dell’opinione pubblica.
Si potrebbe legittimamente ipotizzare che l’onestà, la trasparenza, il rigore e la prevedibilità di sistemi nordici contribuiscano alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Si potrebbe ulteriormente immaginare che la redistribuzione della ricchezza tramite un sistema rigoroso di tassazione progressiva abbia fatto in modo che la classe media nordica non sia così impoverita e inferocita come in altri angoli dell’Europa, compreso da noi.
È tutto vero, ma racconta solo una parte della storia. La tassa patrimoniale, per esempio, non ha mai fornito una ricetta convincente a queste latitudini. In un Paese come la Svezia, fu introdotta all’inizio degli anni Settanta e una conseguenza fu l’esilio volontario di alcuni dei suoi più celebri miliardari, come il fondatore di IKEA Ingvar Kamprad.
Ma non portò a una crescita del gettito fiscale, che salì approssimativamente solo dello 0,4% del totale. Le tasse patrimoniali e di successione sono state nel frattempo abolite.
Se il sistema fiscale non fornisce una spiegazione soddisfacente a questa beata indifferenza dei nordici verso le loro élite, l’ascesa del capitalismo selvaggio e i successivi tagli al servizio pubblico lo fanno ancora meno.
Si sono verificate anche qui privatizzazioni più o meno efficienti di servizi chiave, quella che Daniel Markovitz chiama la «rivoluzione delle consulenze», dove si subappaltano ai privati elementi chiave dell’amministrazione pubblica nel nome dell’efficienza e del taglio della spesa.
Eppure, tutto ciò non sembra aver prodotto delle smagliature nel tessuto economico e sociale così evidenti come nel resto dell’Occidente. Non si è snaturata la centralità della dirigenza, della burocrazia, del management di lungo corso, come zoccolo duro operativo e perfino identitario nella gestione della cosa pubblica.
Questo singolare rapporto dei nordici verso le loro élite va dunque oltre l’onestà e le tasse alte. Dopo tanti anni di permanenza in Scandinavia, sono arrivato alla conclusione, molto più rilevante per un Paese come il nostro, che la chiave risieda nella consapevolezza che le élite —culturali, economiche, politiche – siano parte integrante della democrazia.
Avete letto bene: nell’egalitario e socialista Nord, credono che la casta abbia un ruolo imprescindibile in un sistema democratico. Prima che il lettore levi gli scudi, mi si lasci spiegare.
Eredi naturali della gentry inglese, le élite sono ovunque i pronipoti ideali dei nobili che decidono di sporcarsi le mani nella cosa pubblica. Hanno il tempo dalla loro parte, e direbbe De Gasperi, possono permettersi di pensare alle prossime generazioni, al contrario dei politici che si preoccupano ciclicamente delle prossime elezioni.
Alexander Hamilton, uno dei padri costituenti americani, li definì nel Federalista «gli arbitri imperiali»: individui che hanno il compito di tutelare l’interesse collettivo, evitando quelli speciali che inquinano anche le migliori intenzioni. Prima che mi si accusi di sfrontato elitismo, vorrei citare anche Thomas Jefferson, un altro padre costituente, quando scriveva:
Concordo che esiste un’aristocrazia naturale fra gli uomini. Le ragioni di questa sono la virtù e il talento. C’è anche una aristocrazia artificiale, fondata sulla ricchezza e dalla nascita. […] Considero l’aristocrazia naturale il più prezioso dono della natura, per la direzione e la fiducia nel governo della società. […] Potremmo arrivare a dire che la forma di governo migliore, quando offre nel modo più efficiente una selezione pura di questi aristoi naturali negli uffici del governo.
Il modello scandinavo rappresenta il perfezionamento di questa filosofia. Il ruolo di questi aristoi naturali non è classista, ma più simile a quello del medico di famiglia, il cui parere viene regolarmente richiesto e le cui indicazioni non sono messe in dubbio.
Il contratto sociale è basato in parte su una delega dell’autorità a gruppi tenuti a debita distanza dalla democrazia e protetti dalle sue deformazioni.
L’esempio più calzante sono le commissioni parlamentari di inchiesta. Mentre spesso queste commissioni rappresentano un sotterfugio dei parlamenti per schivare decisioni impopolari, il presupposto è che i contenziosi più spinosi debbano essere sciolti dai vincoli dell’agone politico e portati al tavolo degli esperti.
Ecco che allora il mistero buffo delle amate élite comincia a svelarsi: Alla base c’è un fattore fondamentale che la letteratura sulla governance chiama «autonomia burocratica». L’autonomia burocratica, ci dice lo studioso americano Daniel P. Carpenter, si verifica quando «i burocrati prendono iniziative […] che i politici e le lobby rispettano, anche quando avrebbero preferito che fosse stata presa un’altra iniziativa (o che non avessero preso nessuna iniziativa)».
Un Paese è ben governato quando la politica protegge l’autonomia burocratica dei tecnici dello Stato e si prende la responsabilità delle scelte. In quel caso, e solo in quel caso, la burocrazia sarà percepita dai cittadini come imparziale, efficiente e veramente depositaria del mandato di attuare politiche nel nome del bene comune. E dal momento che le maggiori riforme devono essere sostenute e decise da differenti coalizioni politiche, l’autonomia burocratica assicura continuità all’azione di governo.
L’autonomia della tecnocrazia è l’impalcatura del buongoverno. È questa una delle eredità più durature di Max Weber, quella che vede la burocrazia come una delle forme più evolute in cui l’autorità politica si è storicamente manifestata: dopo il modello di autorità tradizionale (religioso o patriarcale), quello carismatico (dove l’autorità viene presentata come un dono divino), l’autorità burocratica è per Weber il vero fattore determinante dello Stato moderno.
La burocrazia risponde ai criteri di razionalità dello Stato di diritto e questi professionisti delle regole godono, o dovrebbero godere, di maggior fiducia rispetto ai non professionisti.
In Europa settentrionale, l’autonomia della burocrazia ha giocato questo ruolo sistemico nella formazione dello Stato. Bo Lidegaard, un diplomatico e giornalista danese, me l’ha raccontata così:
«Buon governo in lingua danese significa che hai bisogno di trasparenza e coerenza completa nel modo in cui servi i cittadini. Questo perché lo Stato sociale si basa sui diritti dell’individuo. Nello Stato di diritto, la burocrazia ha l’obbligo di assicurarsi che tu riceva esattamente ciò che ti spetta, niente di più, niente di meno».
Verrebbe da dire che in Scandinavia, Max Weber è vivo e lotta insieme a noi.
I fallimenti nell’Europa meridionale, al contrario, sono spesso collegati a forme più o meno accentuate di clientelismo nella cosa pubblica, che anche quando non si qualificano come corruzione, limitano la possibilità di creare una gestione dello Stato basata sul merito.
Il cronismo e il nepotismo confondono gli interessi privati all’amministrazione pubblica. Ma il problema di fondo è che determinano una burocrazia non autonoma e asservita al potere politico.
Un aneddoto può aiutare a chiarire meglio il concetto. Alcuni anni fa, in Danimarca, il bestseller nella saggistica fu un lavoro di giornalismo investigativo di tale Jesper Tynell intitolato “Mørkelygten”, la cui traduzione italiana sarebbe: “La luce che oscura.”
Per intenderci, il libro sollevò il tipo di interesse e indignazione riservato in Italia a “La Casta” di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Solo che, mentre Stella e Rizzo si occupavano di sprechi, abusi e azioni al limite o spesso ben oltre la legalità, Tynell si era occupato esclusivamente di scandali causati dalla mancanza di autonomia burocratica.
Aveva preso in esame una dozzina di casi, dai sussidi di disoccupazione alla scelta del governo di inviare un contingente militare in Iraq, nei quali la burocrazia ha interpretato leggi e statistiche in modo selettivo per asservirsi alle necessità e richieste del ministro di turno.
Il titolo, “La luce che oscura”, era proprio mirato a spiegare come la burocrazia avesse deliberatamente scelto di illuminare aspetti che facevano comodo alla politica e oscurare quelli che invece avrebbero fornito al processo decisionale e all’opinione pubblica la vera visione della realtà.
Non è una esagerazione sostenere che il pubblico italiano avrebbe difficoltà a capire dov’è lo scandalo. Una burocrazia che non è inefficiente, lenta o corrotta, ma al contrario è zelante nel raggiungere gli obiettivi richiesti, ha solo il presunto demerito di essersi asservita in alcuni casi al potere politico.
È però una questione che solleva domande importanti sulla legittimità e il controllo del potere. Una burocrazia che è protetta dalla pressione politica e le passioni popolari è per definizione non soggetta allo scrutinio che i cittadini esercitano attraverso il voto. Paradossalmente, quindi, il buongoverno non è intrinsecamente collegato alla democrazia.
Non a caso, un sinonimo di burocrate è «mandarino»: la Cina è stato il primo Paese al mondo ad aver organizzato un concorso per il pubblico impiego, nel terzo secolo avanti Cristo. Da sempre, uno standard di performance burocratica è la tradizione cinese di accesso meritocratico al pubblico servizio. E la Cina è stata tante cose, ma non una democrazia. Fukuyama arriva a sostenere che «l’abilità di un governo di fare e applicare le regole e di fornire servizi si misura a prescindere del fatto che il governo sia democratico o meno».
È una tesi controversa, che Fukuyama spinge anche oltre, arrivando a sostenere che è stata proprio la democratizzazione a causare il divario di buongoverno fra il Nord e il Sud dell’Europa. Secondo questa lettura, gli alti standard di governance nell’Europa settentrionale sono da attribuirsi al fatto che in questi Paesi il suffragio elettorale fu allargato in tempi graduali e relativamente tardi.
In Europa meridionale, invece, la democrazia è arrivata tutta insieme e troppo presto rispetto al processo di costruzione dello Stato, lasciando ampie sacche dell’apparato dello Stato alla mercé di interessi particolari ed elettorali.
Tesi appunto discutibile, perché mette in dubbio persino la bontà delle scelte che portarono alla fine dei regimi di Mussolini, Franco, Salazar o dei colonnelli in Grecia.
In tutto questo la Scandinavia è forse un precursore, ma non un’eccezione. Il giornalista del New Yorker George Packer ricorda con nostalgia l’esperienza americana degli anni Cinquanta, caratterizzata da individui che sapevano «mantenere integro il centro nella politica, nel business e nei media».
Fareed Zakaria, giornalista americano, ha osservato come nel passato avvocati, notai, giornalisti e professori avessero ruoli rispettabili nella società proprio in virtù del loro essere intrecciati al tessuto sociale di appartenenza. Ricorda come sul Titanic alcuni passeggeri di prima classe si rifiutarono di salire sulle scialuppe di salvataggio, in modo da dare precedenza alle donne e ai bambini.
Questo tipo di dovere era qualcosa che ci si attendeva dalle élite. Qualunque sia la loro provenienza, l’aristocrazia naturale è quella che in Italia consideriamo infusa di «senso dello Stato». Un codice morale non scritto, incarnato nell’immaginario collettivo da eroi civili come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino o da statisti come Carlo Azeglio Ciampi o, oggi, Mario Draghi, per i quali il servizio pubblico è ritenuto il segno più alto di virtù civile.
Oggi assistiamo al fenomeno opposto: così come capitani d’industria falliti ricevono bonus milionari prima di essere licenziati, le élite salvano la pelle nel naufragio perché ne hanno i mezzi. Governi e parlamenti sono bombardati da aziende, fondazioni, think tank e media che non prestano la loro indipendenza ma vendono la loro parzialità.
La Scandinavia non è immune alla mercificazione della vita pubblica. Il successo planetario di Borgen, la serie televisiva che narra con dovizia di particolari le peripezie familiari e pubbliche di una Primo Ministro donna, si apre con la confessione:
«Tutti hanno diritto a una macchina nuova e una cucina bellissima, una grande famiglia, un’amante e uno yacht. Viviamo in un mondo dove siamo occupati a perseguire la nostra felicità. […] I danesi darebbero tutto per la solidarietà. Sono sempre pronti a fare sacrifici. Ma ce ne siamo dimenticati».
L’ubiquità della tecnologia, i crediti a buon mercato, la gratificazione istantanea allettano e tentano i cittadini come in ogni altro Paese dell’Occidente. Eppure, questo trend che accomuna la Scandinavia al resto del mondo occidentale non ha scalfito il rispetto per la formazione e il ruolo della casta.
I cittadini continuano a rispettare i politici. Come per il medico di famiglia, si affidano agli esperti – e non a ricerche su Google – per le domande sulla gestione della cosa pubblica a cui non possono trovare risposta. È un rispetto reciproco e non scontato, ma meticolosamente curato e ricercato. Quando questo avviene, la parola «tecnocrazia» non è usata come dispregiativo, anomalia o aberrazione ma come fondamento dell’impalcatura del buongoverno.
Fabrizio Tassinari è il direttore esecutivo della School of Transnational Governance presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, Italia e fellow del Berggruen Institute di Los Angeles.
“La Stella Polare: Dispacci dal futuro del buongoverno”, da cui questo è stato tratto e adattato questo saggio, è uscito per Rubbettino.
Altre Rassegne
- rainews.it 2021.02.18
Tassinari: il fisco e la lezione danese - linkiesta.it 2021.02.11
In cerca del buongovernoIl modello scandinavo è sapere che le élite sono il cardine della democrazia
di Fabrizio Tassinari