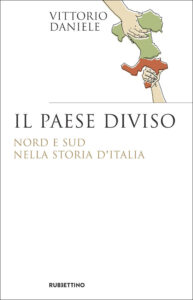Nel suo ultimo libro Vittorio Daniele riprende la sua tesi sui ritardi del Mezzogiorno: è “colpa” della geografia se il Sud è rimasto al palo. Pregi e limiti di una lettura basata solo su una visione economica
È una geniale intuizione dell’economista cosentino Antonio Serra il motivo ispiratore de Il Paese diviso. Nord e Sud nella Storia d’Italia (Rubbettino, Soveria Mannelli 2019), l’ultimo libro di Vittorio Daniele dedicato alla risorgente questione meridionale.
La citazione, contenuta alla fine del volume, è inequivocabile e giustifica tutta la costruzione, suggestiva e in buona parte convincente, di Daniele e val la pena di riportarla in maniera estesa:
«Nel suo Breve trattato del 1613, Antonio Serra considerò le cause, “gli accidenti” che, a suo giudizio, facevano abbondare i regni d’oro e d’argento. Tra quelli che chiamava “accidenti propri” c’era il “sito”, ovvero la posizione geografica in cui ciascun regno si trovava “a rispetto d’altri regni o d’altre parti del mondo”. Dal sito dipendeva l’“accidente del traffico grande”, cioè il flusso dei commerci» [pag. 227].
Perciò, «sotto quest’aspetto […] il Regno di Napoli era svantaggiato a causa della peculiare geografia italiana […]. Un sito “pessimo”, aggiungeva Serra, perché “non bisogna mai passare per quello ad alcuno per andare ad altro paese. Sia di qualsivoglia parte del mondo e voglia andare in qualsivoglia altra, non passerà mai per il Regno se non vi vuol passare per suo gusto e allungare la strada”. Occupando l’estremità della penisola, il Regno di Napoli non era punto di snodo o crocevia di commerci e ciò influiva negativamente sulla sua prosperità» [pag. 227].
Il professore di Politica economica della Magna Graecia di Catanzaro chiude, con questo forte elemento di determinismo geografico – ripreso da uno dei padri dell’economia moderna -, non solo il suo libro, ma anche il dibattito iniziato nove anni fa assieme a Paolo Malanima, professore di Storia economica e direttore dell’Issm (Istituto di studi sulle società del Mediterraneo) presso il Cnr, con cui scrisse nove anni fa Il divario Nord-Sud in Italia, 1861-2011 (Rubbettino, Soveria Mannelli 2011), diventato un classico del nuovo meridionalismo.
Un dibattito a due poli sul Sud
Non abbiamo parlato di determinismo geografico a caso, perché questo elemento, presente sempre nelle riflessioni degli economisti, era già preponderante nella lettura di Daniele e Malanima e diventa addirittura centrale nell’impostazione de Il Paese diviso.
Di più: questo determinismo è diventato uno dei due poli del dibattito, sfociato a più riprese nella polemica aperta, con l’altra visione del nuovo meridionalismo, che fa leva invece su una lettura mista, in cui i dati economici si intrecciano con quelli politici, di cui è un esponente più che credibile l’economista Emanuele Felice, autore del notevole (e fortunato) Perché il Sud è rimasto indietro (Il Mulino, Bologna, ultima ed. 2016).
A dirla in parole povere, i termini del dibattito sono i seguenti: il Mezzogiorno è rimasto indietro rispetto al Settentrione per colpa delle sue classi dirigenti oppure perché, a causa della sua marginalità territoriale, ha avuto un deficit di sviluppo anche nella selezione delle sue élite?
Ancora: il divario tra Nord e Sud è stato l’esito di scelte politiche oppure era già contenuto in una parte consistente del Mezzogiorno?
Come si vede, non è una questione di sfumature: mettere l’accento sull’aspetto politico del problema, come ha fatto Felice, significa ridimensionare gli aspetti non direttamente umani, quindi anche l’influsso del territorio. Viceversa, far leva sull’aspetto territoriale, significa inglobare nella lettura economica l’aspetto politico.
Ma c’è anche una questione di metodo: con la lettura politica si esce dalla storia economica tout court, alla quale invece Daniele si aggrappa con le unghie e con i denti.
Non tocca a chi scrive dire chi delle due parti abbia ragione in questo dibattito di cui la rete conserva molte tracce (i più curiosi possono spulciare academia.edu, in cui troveranno i saggi, in inglese e in italiano, con cui Felice, da un lato, Daniele e Malanima dall’altro, se le sono dette di santa ragione, nei limiti dell’etichetta accademica).
Gli usi impropri del meridionalismo
Quanto finora si è detto serve a ribadire che questo è un dibattito di alto profilo scientifico pieno di ricadute politiche, potenziali ed effettive, e di grande portata.
Soprattutto, è un dibattito che ha poco a che fare con le pretese dei cosiddetti revisionisti antirisorgimentali che hanno tentato di appropriarsi – con la consueta, capziosa approssimazione e comunque in maniera indebita – degli studi di Daniele e Malanima dei quali sembra interessare loro solo la tesi che tra Nord e Sud, prima dell’Unità d’Italia, i divari fossero minimi. E, tra le varie, lo prova la recensione dedicata da Pino Aprile a Il Paese diviso (leggi qui), che si risolve nell’ennesimo tentativo di mettere il cappello sul pensiero del prof di Catanzaro.
Al riguardo, basta una lettura non superficiale per capire che Daniele intende tutt’altro: i bassi divari erano tali in un Paese, l’Italia immediatamente pre e post unitaria, povero, dotato di un’economia in gran prevalenza agricola e con un’industrializzazione minimale, a Nord come al Sud.
Anche i tentativi delle amministrazioni borboniche, al riguardo, spostano pochissimo il quadro: molte attività industriali (si pensi alla produzione della seta, di cui la Calabria deteneva il primato) non erano altro che attività artigianali a conduzione individuale o familiare ma sempre di modesta entità, che si sviluppavano in un’economia spesso di stretta sussistenza. Invece, le industrie vere e proprie (ad esempio, le ferriere) sopravvivevano solo grazie al particolare regime fiscale borbonico, mite all’interno delle Due Sicilie ma duro nei dazi sulle importazioni.
In pratica, era un sistema chiuso con una sua geografia economica a macchia di leopardo, in cui alcune zone davano i punti al Nord (così per alcuni settori dell’agricoltura nei confronti del Lombardo-Veneto, che pure era lo Stato preunitario più ricco e meglio amministrato) e altre galleggiavano nell’economia di sopravvivenza.
Ma resta un dato imprescindibile nell’analisi di Daniele: il Sud era una macroarea marginale di un Paese marginale.
Non a caso, questa lettura è ribadita nelle Conclusioni del libro:
«Questo svantaggio [del Sud, Ndr] divenne più rilevante quando, con la prima rivoluzione industriale, il baricentro economico mondiale si spostò verso l’Europa del Nord. Allora si verificò un ribaltamento, un “rovescio” nella fortuna economica delle nazioni. Il Mediterraneo, da centro qual era, divenne periferia» [pag. 228].
La geografia come destino
L’impatto dell’Unità sul Sud fu duplice: ne fece evaporare le industrie, anche di grandi dimensioni, con la fine del protezionismo e ne danneggiò l’economia agricola, in seguito alle politiche protezionistiche adottate a fine ’800 per lanciare l’industrializzazione del Nord-Ovest.
Un fatto voluto? Senz’altro le decisioni politiche, prese da tutta la classe dirigente italiana, ebbero il loro peso. Ma, se si comprende bene il discorso di Daniele, era anche una scelta obbligata: industrializzare il Nord significava agganciare l’Italia all’«economia-mondo» e questo aggancio non poteva che avvenire attraverso le zone più prossime alle aree industrializzate, o comunque ricche, cioè la Francia e la Mitteleuropa.
Dunque, la scelta operata dalle classi dirigenti non fu di depauperare il Sud a vantaggio del Settentrione, come ripetuto dalle caricaturali vulgate neoborb, ma di industrializzare l’Italia nell’unico modo possibile e il depauperamento dell’agricoltura meridionale fu una conseguenza di questa scelta e non un suo motivo.
Se le cose stanno così, è difficile contestualizzare in questa logica di determinismo geografico la valutazione di Daniele sulle politiche di autarchia economica del fascismo, che si tradussero in un’estensione massiccia delle monocolture a Sud (la famosa e per molti famigerata battaglia del grano).
L’autarchia agricola, in quest’ottica, non dovrebbe essere altro che una conseguenza della politica protezionista adottata nel Ventennio per puntellare il soccorso alle industrie attuato attraverso l’Iri.
In altre parole, il fascismo riprese e ampliò il protezionismo di fine ’800 per tutelare le aziende italiane, ma aggiunse a questa politica uno spiccato dirigismo economico. In quest’ottica, il ricorso alle monocolture serviva a garantire l’Italia dall’aumento dei costi per l’importazione di prodotti alimentari di cui era carente, soprattutto il grano. E non è forse un caso che la riconversione agricola sia stata operata soprattutto sulle terre bonificate (l’ex Agro Pontino) e sulle aree adibite a pascolo.
Che questa scelta abbia provocato squilibri non ci piove: ne provocano tutte le politiche economiche dirigiste e protezioniste.
Ma tutto ciò non toglie che questo passaggio storico meriti ben altri approfondimenti di quelli contenuti ne Il Paese diviso. Messa così, l’analisi di Daniele non va troppo oltre l’antifascismo rituale che continua ad essere quasi obbligatorio per gli accademici del Sud (e c’è da dire, per onestà, che anche Emanuele Felice tratta il fascismo con analoga sbrigatività).
Alcuni limiti storici
Con un passo indietro emerge un’altra lacuna non da poco. Ci si riferisce alla repressione del grande brigantaggio, trattata nel secondo paragrafo del secondo capitolo del libro [da pag. 70 a pag. 75].
In questo caso, il vizio deriva dal ricorso a fonti non aggiornate: Daniele cita a profusione classici come Molfese o Villari oppure mafiologi come Ciconte, lega il brigantaggio alle insorgenze contadine e alle questioni demaniali e finisce col diluirlo nella questione sociale.
Il quadro che ne esce è piuttosto distorto: secondo il prof di Catanzaro, la repressione del brigantaggio, più che il brigantaggio in sé, avrebbe inferto un colpo micidiale all’economia del Sud grazie anche al suo costo enorme in vite umane.
Questa lettura è piuttosto vecchia, specie rispetto alle recenti acquisizioni storiografiche sulla lotta al brigantaggio, di cui offre un brillante esempio La guerra per il Mezzogiorno di Carmine Pinto (Laterza, Bari 2019) che addirittura rovescia l’impostazione gramsciana finora predominante, dato che il brigantaggio vi viene letto come fenomeno politico-criminale e non come insorgenza socio-politica.
In questo caso, la prospettiva cambia non poco: fu il brigantaggio a colpire l’economia (oltre che la sicurezza) del Sud e la sua repressione – tra l’altro invocata da fette consistenti della popolazione, inclusi i ceti più poveri – un rimedio imprescindibile per restituire a buona parte dei territori ex borbonici i fondamentali della vivibilità.
Non è il caso di entrare nel merito, tuttavia si può osservare che Daniele sorvola del tutto l’analisi di Pinto, di cui avrebbe comunque potuto tener conto, visto che il saggio di quest’ultimo è uscito nella primavera del 2019, cioè mesi prima de Il Paese diviso, pubblicato lo scorso novembre.
Analoghe lacune emergono nel sesto capitolo del libro, dedicato in buona parte alla critica e alla confutazione delle vecchie teorie antropologico-culturali sull’arretratezza del Sud. Una confutazione doverosa, ci mancherebbe. Doverosa anche a livello logico, perché sostenere la prevalenza del determinismo geografico implica anche la critica agli altri determinismi.
Tuttavia, appare quantomeno scorretta la lettura del positivismo lombrosiano come base del pregiudizio antimeridionale. In questo caso, Daniele si limita ad alcune citazioni tratte dall’edizione del 1897 de L’Uomo delinquente di Cesare Lombroso e ne collega il pensiero in maniera piuttosto arbitraria elle opere di autori più palesemente razzisti, come ad esempio Alfredo Niceforo, che fu allievo di Lombroso solo in maniera piuttosto indiretta.
Anche in questo caso il prof di Catanzaro sorvola le più recenti acquisizioni sul pensiero lombrosiano, esemplificate di recente dalle ricerche di Maria Teresa Milicia.
Infine c’è un ulteriore nodo irrisolto, dovuto soprattutto al taglio d’analisi del libro, che mette in secondo piano l’azione politica e la riduce essenzialmente al ruolo dello Stato.
La crescita del Sud
In maniera correttissima Daniele individua nel ventennio 1950-1970 la fase di maggior crescita del Sud, che inizia a convergere col Settentrione per la prima (e purtroppo unica) volta. Dagli anni ’70, invece, inizia la decrescita e riprende il distacco, che diventa galoppante a partire dal nuovo millennio.
In questo, l’analisi dell’economista calabrese collima alla perfezione con le riflessioni di Salvatore Lupo e di Paolo Macry. Ma la posposizione del dato politico impedisce di trarre le dovute conseguenze.
L’Italia che visse il boom economico, in cui il Nord trainò il Sud fu un Paese dalle strutture amministrative fortemente accentrate, così come lo era stato in età liberale e durante il fascismo e in cui le continuità col Ventennio restavano fortissime, a partire dalla composizione del deep State per continuare con gli strumenti di intervento pubblico nell’economia, svolto con la stessa impostazione dirigista.
Fu grazie alle strutture accentrate che lo Stato riuscì a redistribuire redditi e finanziamenti, perché al tradizionale rapporto socio-economico tra Nord e Sud riuscì a sovrapporre quello, politicamente più efficace, tra centro e periferie. In pratica, un rapporto centripeto che frenò di molto la marginalizzazione del Mezzogiorno.
Non è un caso che la riapertura della forbice tra le macroaree del Paese coincida con l’istituzione delle autonomie regionali e che le ulteriori divaricazioni coincidano con l’aumento di queste autonomie e con l’integrazione europea.
In pratica, l’Italia si è presentata all’appuntamento dell’Ue con le strutture statali indebolite e senza più il controllo della politica valutaria. Quanto tutto questo abbia creato distorsioni nell’uso dei fondi europei (che, opportunamente investiti avrebbero potuto contribuire a una nuova chiusura della forbice) è da vedere.
Purtroppo, però Daniele non offre indicazioni in tal senso, perché evita di analizzare l’impatto delle autonomie regionali e locali sul divario Nord-Sud. Peccato.
Una nuova questione meridionale?
Il Paese diviso è una brillante riflessione che soffre, tuttavia, dei limiti di un’impostazione disciplinare piuttosto rigida, in cui il tentativo di mettere in primo piano la storia economica si risolve in una svalutazione della storia tout court e delle altre sue specialità, a partire dalla storia politica.
Tuttavia il libro di Vittorio Daniele ha un pregio non proprio da sottovalutare, se lo si legge con onestà e correttezza: è un tentativo forte e non privo di solidi fondamenti, di ridare alla questione meridionale fondamenta scientifiche e di reinserirla nel dibattito accademico senza passare per le forche caudine della polemica politica.
Ma, per quanto la si voglia minimizzare e ridimensionare, la politica fa comunque capolino e c’è da dire che, purtroppo, il determinismo geografico finisce per assolvere le classi dirigenti meridionali o per fornire loro molte attenuanti. Proprio il contrario di quel che ha fatto Emanuele Felice con la sua lettura appassionata e carica di passione civile.
Ma ciò non toglie che si debba riconoscere a Daniele un altro merito: aver tenuto le proprie riflessioni a distanza di sicurezza dalla cultura del piagnisteo che oggi tende a tradursi in una cultura della rivendicazione a prescindere, anche grazie all’opera di chi tenta di appropriarsi di queste elaborazioni.
Non è davvero poco per un libro da leggere e meditare, perché riesce ad essere costruttivo anche grazie ai suoi limiti.
Altre Rassegne
- La Repubblica 2021.03.12
A che punto è l’Unità d’Italia
di Corrado Augias - indygesto.com 2020.09.12
Il Paese diviso, una nuova lettura della questione meridionale
di Saverio Paletta - Gazzetta del Sud 2020.09.08
Prestigioso premio al prof Daniele - L'Indice dei Libri del Mese 2020.06.01
Separati in patria
di Mario Bova - Il Quotidiano del Sud 2020.05.31
Il Paese diviso
di Egidio Lorito - Storia in Rete 2020.02.19
Ecco com’era l’Italia di 150 anni fa
di Pino Aprile - corrierepl.it 2020.01.25
Il Paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia - Il Mattino 2019.12.27
«Il divario Nord-Sud dovuto alla geografia»
di Ugo Cundari - zoomsud.it 2019.12.20
Scuola: nasci nel Sud e sei penalizzato
di Filippo Veltri - La Gazzetta del Mezzogiorno 2019.12.22
Se le pagine raccontano un Sud diverso da come lo immaginò Lombroso
di Lino Patruno - Il Quotidiano del Sud 2019.12.22
Se il Sud è rimasto indietro è colpa della geografia
di Antonio Cavallaro - Il Mattino 2019.12.20
All’origine del divario tra il Nord e il Sud
di Isaia Sales - Il Quotidiano del Sud 2019.12.18
Scuola: nasci nel Sud? Allora sei penalizzato
di Filippo Veltri - pinoaprile.me 2019.12.09
“Il Paese diviso”, del prof. Vittorio Daniele. Un libro imperdibile - letture.org 2019.11.27
“Il paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia” di Vittorio Daniele