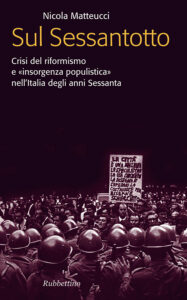Mi ha fatto impressione, domenica scorsa, leggere prima, su queste colonne, l’analisi (esemplare) di Sergio Fabbrini sul populismo, e ritrovare lo stesso tema in un saggio del lontano 1970 di Nicola Matteucci, uno dei padri del pensiero liberale europeo. Le pagine di Matteucci (pubblicate originariamente sul Mulino, e riproposte da Rubbettino nella raccolta del pensatore bolognese Sul Sessantotto) sono di drammatica e impressionante attualità.
Non solo per la lettura critica del ‘68, tanto più utile in questo cinquantenario, occasione in parte mancata per una riflessione su quell’anno; ma, soprattutto, per le profetiche parole con le quali Matteucci fotografa (quasi mezzo secolo fa!) l’«insorgenza populista»: «Con il populismo si coagula una nuova sintesi politica, che non può essere definita… conservatrice o progressista, perché supera e mantiene entrambe le posizioni, affermando da una lato una volontà autoritaria, che nella fretta del fare è sempre più insofferente degli impacci e delle remore imposte dalle procedure costituzionali di una democrazia moderna, e dall’altro, quando arriva al potere, manipola le masse con slogans genericamente rivoluzionari. A questo populismo si accompagna un diffuso anti-intellettualismo, un atteggiamento di rivolta contro la ragione critica, che è poi una rivolta contro lo specialista, l’esperto, lo studioso, in nome di sentimenti e passioni elementari e primitiviste, dei quali si fanno portatori, in primo luogo, i giovani che si sottraggono al controllo dei rispettivi partiti».
Come dire meglio, tenendo conto anche del fatto che l’analisi di Matteucci risale ad anni in cui gli «slogans» si scrivevano ancora sui muri, e non sugli schermi dei cellulari (allora intesi peraltro come strumenti di bieca repressione poliziesca)?
Oltre che per l’impressionante profezia, le parole di Matteucci colpiscono anche perché fanno giustizia di alcuni luoghi comuni ai quali ci siamo affezionati e che rischiano di farci deragliare nell’affrontare quella che non è più un’«insorgenza» ma «una minaccia all’infrastruttura della democrazia liberale», come scrive Fabbrini. Matteucci ricollega il successo incombente del populismo alla debolezza della cultura riformista, e alla «congiura del silenzio» di cui cadeva vittima, negli anni in cui scriveva, la cultura liberale (due lacune esplose fragorosamente, appunto, nel ’68).
Che l’analisi non si adatti solo all’Italia veniva confermato nello stesso week end da un intervento di Gillian Tett sul “Financial Times”, secondo la quale «l’economia da sola non basta a spiegare» il fenomeno del populismo, che è alimentato, più che dagli effetti critici della globalizzazione, dal progresso tecnologico che ha reso Internet un elemento distruttivo non solo della finanza o del commercio ma anche della politica, con gli «elettori che rispondono con strepiti di rabbia anti-sistema».
La Rete e i social (non in sé, ma nell’uso distorto che sembra purtroppo essere diventata la norma) preoccuperebbero ancora di più Matteucci, ma lo rafforzerebbero nella sua convinzione di fondo: che l’unico modo per combattere il populismo è ristabilire la forza di una cultura politica riformista, diffidente verso «il profondo anti-intellettualismo, l’avversione per la cultura e la sua capacità a formare coscienze libere». Retorica? No: politica, nel senso migliore, e nel segno delle conclusioni di Fabbrini che richiama tutti, a partire dall’informazione, alla responsabilità di contribuire ad «alzare il livello del dibattito civile». Per dirla in termini che a Matteucci occorrerebbe spiegare (ma capirebbe subito), la democrazia rappresentativa e pluralista, cioè liberale, attende, insomma, i suoi “influencer”, gente disposta a spendersi per smontare le fake news, combattere la sfiducia, alimentare canali di formazione dell’opinione pubblica, costruire classe dirigente: missioni tanto più urgenti quanto più evanescente si è fatta la capacità dei partiti (e anche questo Matteucci non avrebbe potuto prevedere) di fare formazione politica e addestramento alle istituzioni.
Insomma, le utopie ritornano: negli anni 50 Mario Ferrara invitava a «dare un matto ai liberali»; oggi, la lucida follia di cui tutti i democratici devono dar prova si chiama riformismo (con annessa capacità di venderlo).
Altre Rassegne
- Il Sole 24ore (.com) 2018.08.08
Contro il populismo una politica riformista
di Salvatore Carrubba