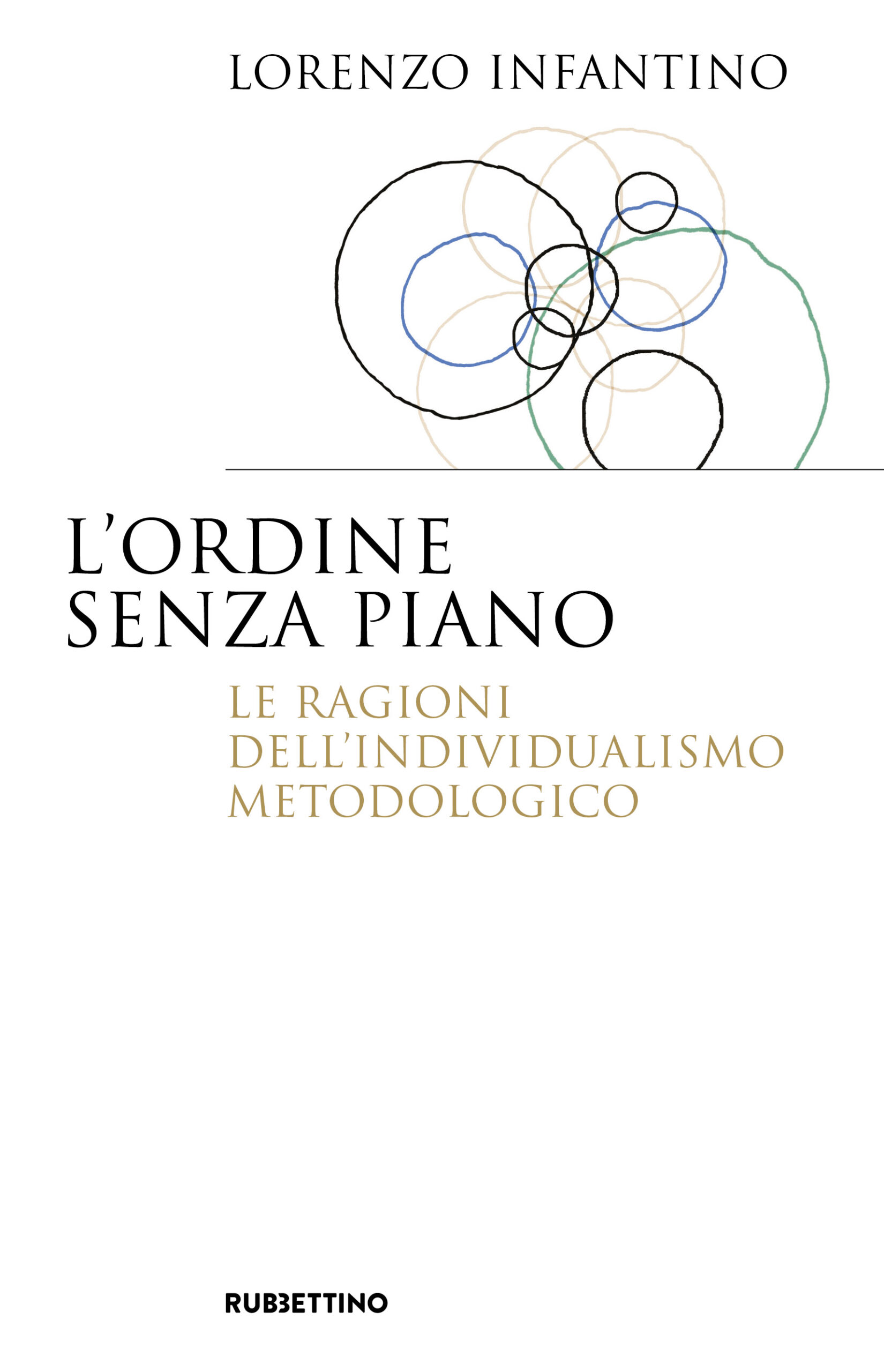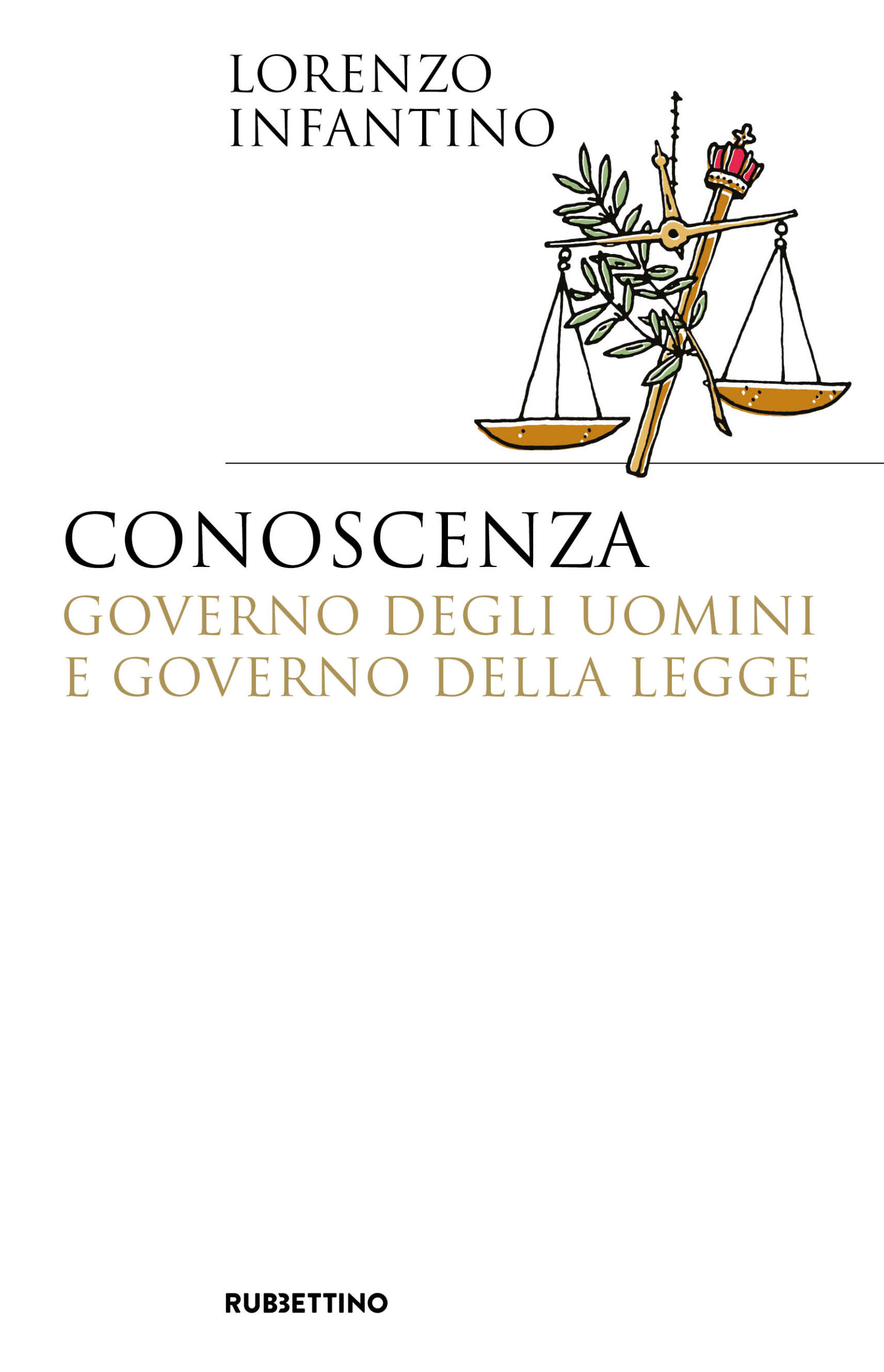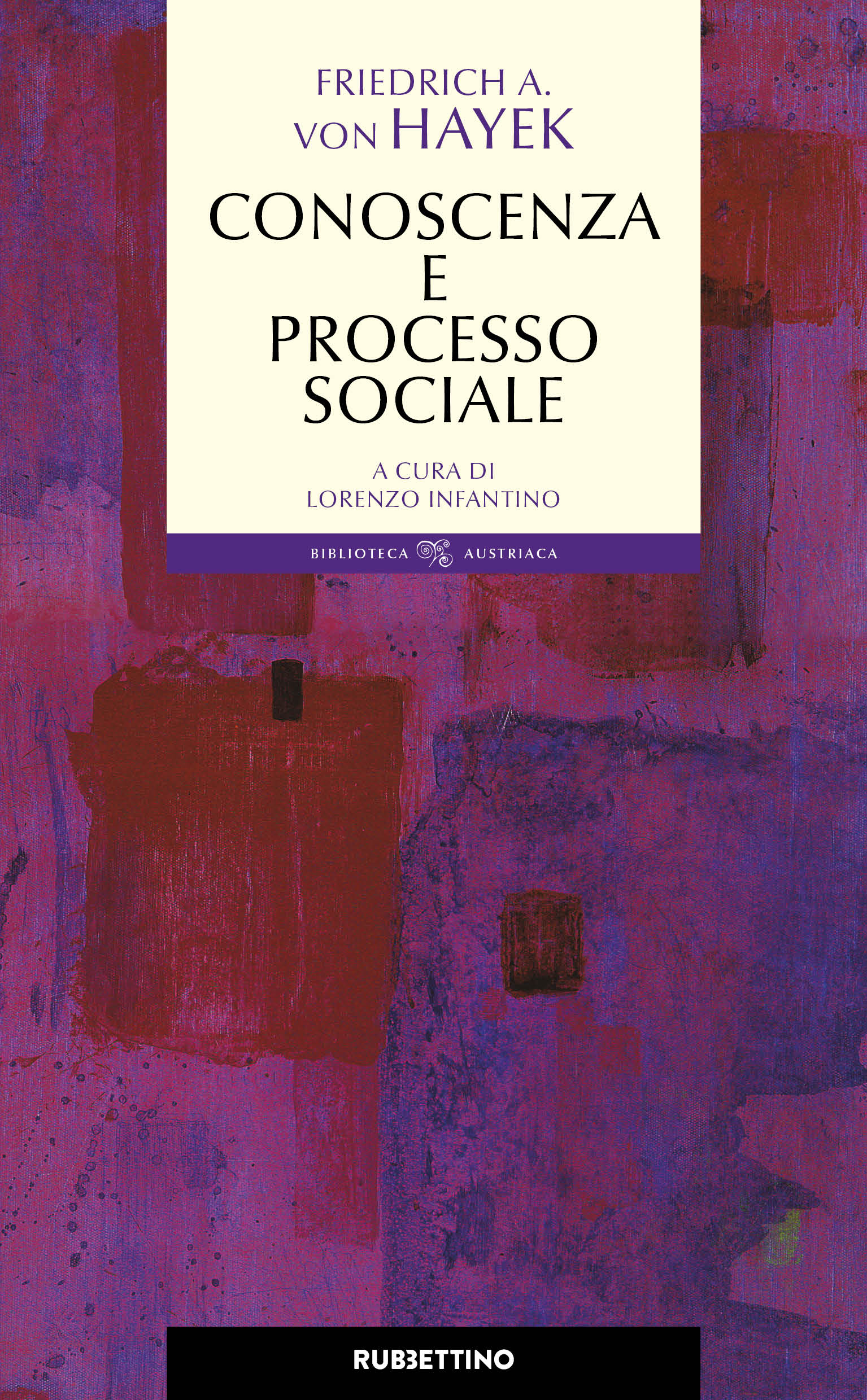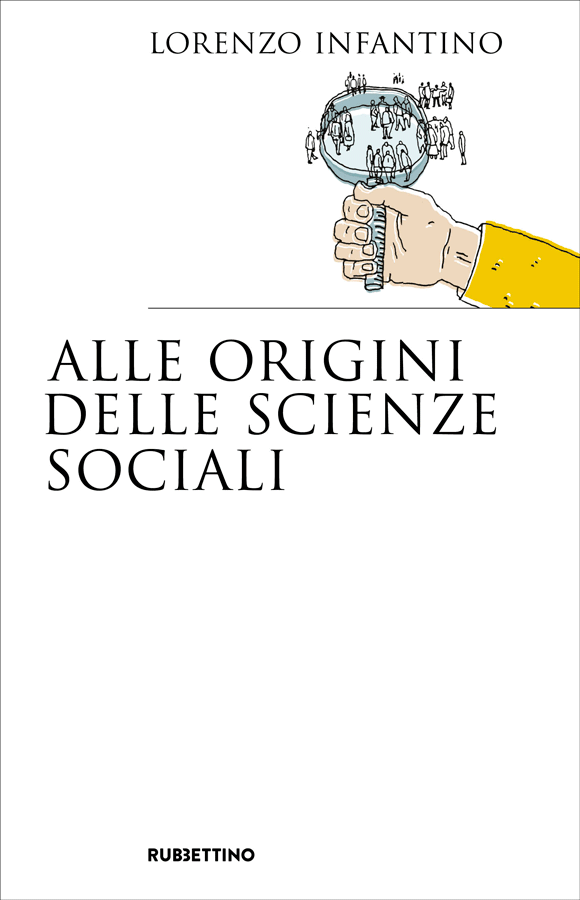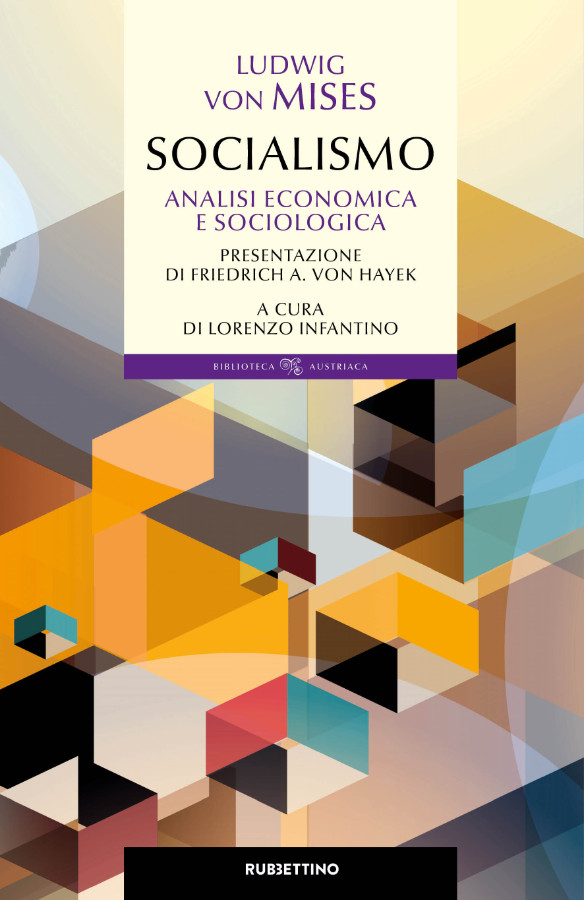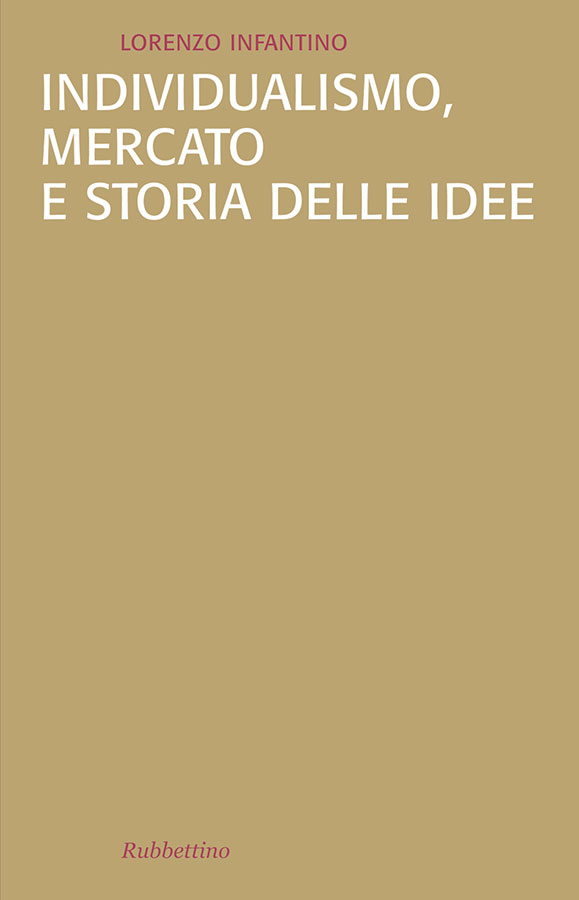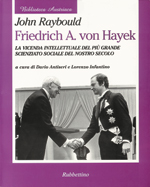L’ordine senza piano
Le ragioni dell'individualismo metodologico
Cartaceo
€20,90 €22,00
L’ordine senza piano è apparso in prima edizione trent’anni fa. È stato subito tra dotto in inglese e spagnolo, ricevendo vari apprezzamenti sul piano internazionale. Pone in stato nascente le scienze sociali; e mostra
L’ordine senza piano è apparso in prima edizione trent’anni fa. È stato subito tra dotto in inglese e spagnolo, ricevendo vari apprezzamenti sul piano internazionale. Pone in stato nascente le scienze sociali; e mostra che tutto ciò che non è direttamente imputabile alla volontà umana non è attribuibile all’intervento di forze misteriose. Accade infatti che, co-adattandosi, le azioni umane producano, oltre agli esiti intenzionali, esiti inintenzionali. Nessuno ha il controllo di tutte le conseguenze prodotte dal proprio agire; e queste possono essere di carattere positivo e di carattere negativo. Ciascuno cerca di trarre vantaggio dalle prime e di eliminare le altre. I punti di mediazione che consentono il co-adattamento delle azioni sono essi stessi esiti non programmati; e danno vita a norme sociali e a costellazioni di norme. Istituzioni come il linguaggio, la famiglia, il diritto, la moneta sono il prodotto del l’azione umana. Non c’è stato però dietro di esse un disegno finalizzato alla loro creazione. Sono state la generalizzata accettazione di esiti inintenzionali di carattere positivo. Il che mostra quanto ingannevole sia la credenza che presenta l’ordine sociale come il prodotto dell’intervento di forze di impossibile decifrazione. L’approccio seguito dall’autore è noto sotto la denominazione di «individualismo metodologico». Esso parte dall’azione dei singoli e ricostruisce in tal modo la trama sociale. Non è da confondersi, come spesso avviene, con lo «psicologismo», quella tradizione di ricerca che vede in tutto ciò che è sociale un’esclusiva proiezione delle intenzioni umane. E si oppone al «collettivismo metodologico», quell’indirizzo di studi che, incapace di riconoscere i limiti imposti dalla nostra condizione di ignoranza e fallibilità, si affida alla volontà di un grande e onnisciente legislatore, a cui ogni decisione debba essere demandata.
Indice
Prefazione
1. Introduzione
1. L’«abuso della ragione»
2. L’economia politica e la scoperta dell’ordine inintenzionale
3. La nascita della sociologia e l’ordine intenzionale
4. La «rivolta contro l’individualismo»
5. L’alleanza contro la società aperta
2. Bernard de Mandeville e Adam Smith: la teoria della «grande società»
1. L’uomo, animale sociale
2. I bisogni e la divisione del lavoro
3. Una «società commerciale» può sopravvivere?
4. Il vantaggio di Ego e il vantaggio di Alter: la «mano invisibile»
5. Sviluppo ateleologico
6. Mandeville: la prestazione altrui è sempre un mezzo
7. Smith: la prestazione altrui è sempre un mezzo (sul principio di «simpatia»)
8. «Das Adam Smith-Problem»
9. La coerenza della teoria smithiana
10. Alcune conclusioni
3. Quale metodo? Una questione di filosofia delle scienze sociali
1. Ordine inintenzionale e metodo individualistico
2. Il metodo individualistico afferma il legame sociale
3. Il metodo individualistico e gli errori dello psicologismo
4. Auguste Comte: il metodo collettivistico e l’impossibilità della «grande società»
5. Karl Marx: tra politica e scienza
4. Durkheim e il metodo collettivistico
1. Durkheim contro la «grande società»
2. Lo Stato come variabile indipendente
3. Durkheim e l’economia politica
4. La società è una realtà sui generis?
5. La società non è una realtà sui generis
6. Tra positivismo e idealismo
5. È possibile una lettura “individualistica” di Durkheim?
1. Gli elementi che rendono possibile una lettura “individualistica” di Durkheim
2. Durkheim al vaglio “individualistico”
3. Durkheim e Spencer
4. Durkheim e Simmel
6. Economisti e sociologi a confronto: Carl Menger e Georg Simmel, Ludwig von Mises e Max Weber
1. Carl Menger: individualismo metodologico e «rivoluzione» marginalista
2. Le “convergenze” fra Carl Menger e Georg Simmel
3. Ludwig von Mises: la teoria dell’azione negli sviluppi del marginalismo austriaco
4. Le “convergenze” fra Max Weber e Ludwig von Mises
5. Le critiche di Mises alla quadripartizione weberiana dell’agire dotato di senso
7. Il primo Parsons tra sociologia ed economia
1. La «morte» di Spencer e l’estromissione di Simmel
2. L’equivoco della costruzione razionale delle preferenze
3. Alla ricerca dell elemento «creativo volontaristico»
4. Il problema del «sistema comune di fini ultimi»
5. Il «teorema sociologistico»
6. La soluzione mancata
7. Costo economico e obbligo sociale
8. Conclusioni
1. «Impariamo a essere degli Io» 291
2. Sociologia ed economia 296
3. Il compito delle scienze sociali 303
Bibliografia 307
Indice dei nomi 32
Rassegna
- Il Sole 24 ore - Domenica 2025.03.02
Impegno civile al servizio della libertà
di Salvatore Carrubba